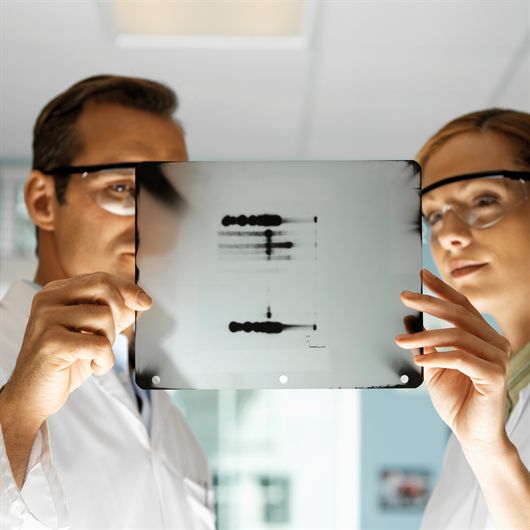Il 26 giugno del 2000 il Presidente americano Bill Clinton e il Premier inglese Tony Blair annunciarono al mondo il completamento della prima bozza del genoma umano, un traguardo storico destinato a cambiare definitivamente la medicina moderna. Oggi, grazie alla tecnologia, è possibile sequenziare un genoma umano in poche settimane spendendo qualche migliaio di euro.
di Moreno Colaiacovo
Con un investimento di oltre 2 miliardi di dollari, il consorzio pubblico guidato da Francis Collins era finalmente riuscito, dopo dieci anni di lavoro, a decodificare, il 26 giugno del 2000, i 3 miliardi di lettere che compongono la nostra sequenza genomica. Oggi, a poco più di dieci anni di distanza, è possibile sequenziare un genoma umano in poche settimane spendendo qualche migliaio di euro, e i più ottimisti confidano che entro la fine di quest’anno sarà raggiunta la fatidica soglia dei 1.000 dollari. Un simile calo dei costi non sarebbe stato possibile senza i progressi tecnologici che hanno interessato il settore della genomica negli ultimi anni. I ricercatori del Progetto Genoma Umano avevano a disposizione una sola tecnica per sequenziare il DNA, il metodo della “terminazione della catena” che era valso il Nobel per la chimica a Frederick Sanger.
Lo scienziato inglese lo sviluppò negli anni ’70, e benché successivamente perfezionato e automatizzato, esso conservava ancora il proprio grande limite: era una metolodogia eccessivamente dispendiosa, sotto il profilo dei tempi e dei costi.
Per accelerare la ricerca genomica occorrevano tecnologie più rapide ed economiche, esattamente quelle che iniziarono a popolare il mercato dal 2005 in poi.
CAMBIAMENTO EPOCALE
La rivoluzione tecnologica che cambiò il modo di fare ricerca sul genoma iniziò con il sequenziatore 454 commercializzato da Roche Diagnostics: in una sola corsa di reazione, questa macchina produceva mille volte i dati ottenibili con il metodo Sanger. Ad essa seguirono il sistema SOLiD di Applied Biosystems e il Genome Analyzer di Illumina; fu in particolare quest’ultima azienda californiana a conquistare la fetta più consistente nel mercato del sequenziamento di seconda generazione.
Il suo HiSeq 2000 è oggi in grado di produrre in otto giorni di lavoro qualcosa come 200 miliardi di basi, più di 60 volte la lunghezza di un genoma umano completo. Le risorse computazionali necessarie per analizzare simili quantità di dati (più di 30 terabyte) sono imponenti, e del resto è proprio l’analisi bioinformatica il vero collo di bottiglia di tutto il processo. Oltretutto, le sequenze generate da questi strumenti sono di piccole dimensioni, una caratteristica che ostacola la fase successiva alla produzione del dato, cioè l’assemblaggio bioinformatico: infatti, non essendo possibile leggere un genoma dall’inizio alla fine senza interruzioni, la procedura prevede la generazione di milioni di frammenti di sequenza che vanno poi riordinati, così come si farebbe con le tessere di un puzzle; chiaramente, più piccoli sono i frammenti, più complesso diventa metterli insieme.
VERSO LA MEDICINA PERSONALIZZATA
La tecnologia, però, cambia velocemente, e già iniziano ad apparire all’orizzonte i protagonisti della terza generazione di sequenziatori, che si è posta l’obiettivo di portare la genomica - finora relegata ai laboratori di ricerca - in ospedali e cliniche, un obiettivo che spera di raggiungere grazie ai progressi nel campo delle nanotecnologie e dei materiali semiconduttori. Tra le più promettenti in questo senso c’è la tecnologia di sequenziamento sviluppata da Ion Torrent, una piccola company americana che la scorsa estate è stata acquistata dal colosso Life Technologies nell’ambito di un affare da 700 milioni di dollari. Poche settimane fa è stato presentato il primo risultato di questo sforzo economico, la Personal Genome Machine: uno strumento delle dimensioni di una stampante, velocissimo, in vendita per una cifra - 50.000 dollari - di dieci volte inferiore al prezzo di un sequenziatore di seconda generazione. Con un calo dei costi così rapido, è lecito pensare che presto potremo acquistare il sequenziamento del nostro genoma per soli 1.000 dollari. Quando quel giorno arriverà, la medicina personalizzata sarà ormai ad un passo: farmaci, dieta e stile di vita saranno adattati al nostro profilo genetico, che sarà memorizzato su una comoda chiavetta USB.
COSA DICE LA SCIENZA
Nei dieci anni che ci separano dalla prima bozza del genoma umano sono state fatte moltissime scoperte sui meccanismi genetici alla base delle patologie. Tuttavia, gran parte di esse riguarda malattie rare che dipendono da un solo gene, come la fibrosi cistica, l’anemia falciforme e la malattia di Huntington. Le patologie più comuni (cancro, malattie cardiovascolari, obesità) sono dovute a complesse interazioni, in cui intervengono sia fattori genetici sia ambientali. Oltre tutto, i geni responsabili non sono mai uno solo, ma decine o forse centinaia: è per questo motivo che ancora oggi è impossibile progettare un test genetico che sia realmente efficace nel predire l’insorgenza di queste malattie. La genomica si trova ora a un punto di svolta, e gli esperti si chiedono come procedere per riuscire a portare finalmente la medicina predittiva nella nostra vita di tutti i giorni. In passato si pensava che le cause delle malattie comuni dovessero essere cercate nelle variazioni genetiche frequenti nella popolazione; seguendo questo paradigma, si sono realizzati centinaia di studi di associazione su scala genomica in cui si esaminano queste varianti nei gruppi di pazienti malati e le si confrontano con quelle di individui sani: l’idea era che le varianti genetiche responsabili della malattia fossero quelle più frequenti nel gruppo dei pazienti. Purtroppo, la questione è molto più complessa: ci si sta accorgendo che forse a essere determinanti non sono singole varianti comuni, ma particolari combinazioni di varianti comuni e rare. Ciò significa che non sarà più sufficiente analizzare il genoma in singole posizioni come è stato fatto finora: per far emergere anche le variazioni più rare, infatti, non esiste altra strada se non quella del sequenziamento diretto dell’intero genoma. Ed ecco perché diventa fondamentale poter contare su tecnologie sempre più economiche.